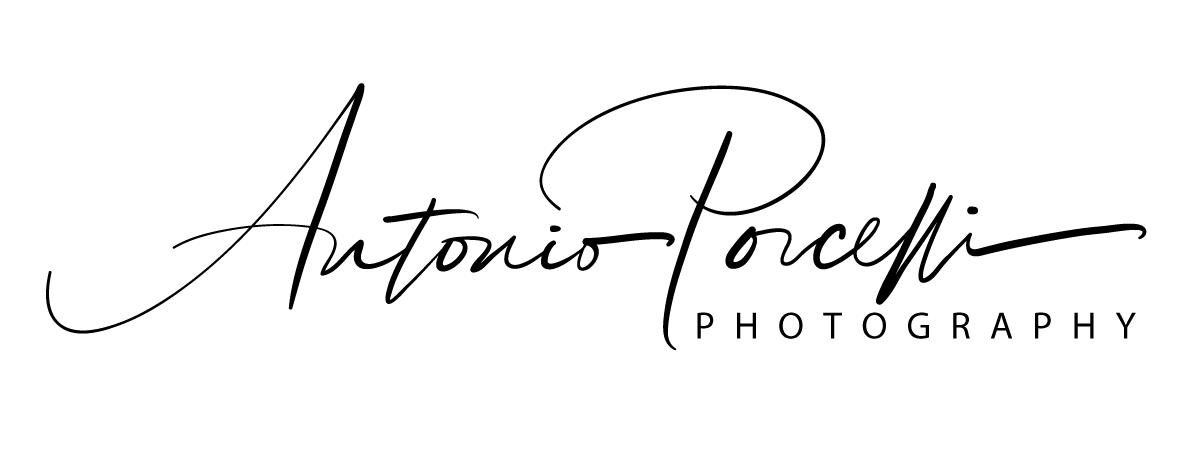Un popolo in cammino
 “Li avevo davvero sentiti quei rumori!”
“Li avevo davvero sentiti quei rumori!”
La temperatura nella tenda era scesa a -25° in poco tempo. Alle 22 Antonina aveva messo nella stufa l’ultimo ceppo di legna e solo mezz’ora dopo eravamo avvolti da un freddo glaciale. Per fortuna, avevo acquistato a Salekard un sacco a pelo “tecnico”: avrebbe retto fino a -30°! Allungata accanto a me una bellissima e morbida canina nera mi rimandava il suo tepore. All’esterno calma piatta, il bianco della neve non restituiva mai un buio completo.
È arrivato all’improvviso. Era un rumore metallico, veniva da fuori, ripetitivo, intenso, sinistro come lo sbattere di due lamiere.
Eppure fuori, nella Taiga siberiana, nulla poteva far pensare ad una dinamica del genere. C’erano solo slitte e cani, quelli della spedizione di Amundsen, socievoli, intelligenti, dall’aspetto sempre sorridente, qui per aiutare quotidianamente i loro padroni Nenci nell’accudire e sorvegliare le renne.
“Erano loro?!”
Nella tenda dormivano tutti. Come anziano del gruppo avevo avuto un posto d’onore accanto ad Aleksandr, il vecchio saggio – più giovane di me – che ora russava profondamente; sopra di lui una bambolina di stoffa, ritenuta sacra e protettrice della tenda, tutto intorno altre otto persone e dieci cani che contribuivano a far salire di almeno un grado la temperatura della gelida notte.
Solo Laura e Nicoletta il giorno dopo mi confidarono di avere sentito quegli stessi suoni.
Quel pomeriggio, al rientro dal vicino accampamento della sorella di Yuri, avevamo visitato uno dei tanti Gulag che, a centinaia, ancora oggi sorgono lungo km di ferrovia ormai abbandonata e semi sepolta dalla neve. Costruiti ai tempi di Stalin con il sudore e il sangue dei tanti prigionieri, spesso innocenti, confinati in una prigione senza sbarre ma con nessuna possibilità di fuga. Era lì che mi avevano parlato della leggenda dei tanti morti e non sepolti che, di notte, si aggirano ancora alla ricerca di un po’ di pace.
 “Se li guardi… potresti impazzire”, mi avevano detto.
“Se li guardi… potresti impazzire”, mi avevano detto.
“Se di notte senti dei rumori non uscire mai dalla tua tenda”.
Erano vissuti in piccole costruzioni di legno e paglia, dai soffitti ormai franati sotto il peso della neve, con finestre forse mai chiuse, pochi legni che a stento oggi rimangono in piedi stretti dalla morsa del ghiaccio. All’ interno, erano rimaste poche brande, ciotole di metallo e, nelle fessure delle pareti, sigarette rotte.
“Si usa così, è un gesto di devozione, un mozzicone per ammazzare il tempo”.
“Non andar via senza aver lasciato un po’ di pane!”
Non lo avevamo fatto, non potevamo saperlo ma Zelfira, la nostra guida locale, era tornata indietro per lasciarlo. La Siberia è la sua terra, cosparsa dei suoi morti, dei suoi ricordi di bambina. Lei sa bene che prima o poi qualcuno mangerà. Quella notte avevo trattenuto la pipì pur di non uscire dalla tenda! Operazione per altro complessa dato che per andar fuori, nel silenzio generale, rotto solo dal russare profondo dei più, bisognava uscire dal sacco a pelo, vestirsi almeno un po’, guadagnare l’uscita cercando di non calpestare nessuno e percorrere almeno una trentina di metri, sotto la neve scricchiolante ad ogni passo, per non lasciare tracce evidenti intorno alla tenda.
Era Antonina a dare il via al nuovo giorno. Bisognava aspettare che si alzasse e mettesse il primo ceppo di legno nella stufa. Un po’ di carta, un fiammifero e come d’incanto la temperatura cominciava a salire. Solo lei ed Elèna, le uniche donne della tenda, potevano occuparsi del focolare, solo loro la mattina potevano posare i due grossi bricchi d’acqua e di tè sulla piastra. Ancora un po’ e i nostri aliti avrebbero finito di emanare quella fitta e insana nebbia; era quello il segnale che finalmente ci si poteva alzare.
Nera, l’avevo chiamata così, tutte le mattine cominciava a colpirmi ripetutamente la spalla con la sua zampa. Il lavaggio del viso era garantito dalle sue profonde e affettuose leccate, qualche carezza da parte mia e il rito ripartiva fino al segnale di Antonina; finalmente poteva abbandonare la tenda!
 Antonina è la moglie di Aleksandr, capace di cucire le pelli di renna con i robusti fili ricavati dallo sfilacciamento del legamento giallo della colonna vertebrale delle stesse renne. Fili intrecciati da rapidi e sapienti movimenti tra bocca e mani fino ad ottenerne uno ancora più resistente ed elastico. Una sera ci aveva mostrato il suo campionario, lavori di grande maestria tramandati di generazione in generazione, spiegandoci come nulla delle pelli doveva essere sprecato. Con le zampe posteriori ottimi stivali decorati, con la pelliccia del collo caldi copricapo e, con più pelli, cappotti lunghi fino alle caviglie.
Antonina è la moglie di Aleksandr, capace di cucire le pelli di renna con i robusti fili ricavati dallo sfilacciamento del legamento giallo della colonna vertebrale delle stesse renne. Fili intrecciati da rapidi e sapienti movimenti tra bocca e mani fino ad ottenerne uno ancora più resistente ed elastico. Una sera ci aveva mostrato il suo campionario, lavori di grande maestria tramandati di generazione in generazione, spiegandoci come nulla delle pelli doveva essere sprecato. Con le zampe posteriori ottimi stivali decorati, con la pelliccia del collo caldi copricapo e, con più pelli, cappotti lunghi fino alle caviglie.
Erano passati già diversi giorni dal nostro arrivo, fino ad allora ci aveva studiato silenziosamente, dandoci quasi l’impressione di ignorarci e continuando a svolgere i suoi compiti come se non fossimo mai arrivati.
Il viaggio da Salekard era avvenuto su due giganteschi fuoristrada Trekor, a sei ruote motrici. Eravamo in sette più Tatiana, la nostra dolcissima guida italiana, di sangue russo-ucraino ma per metà siberiano. La nostra destinazione era stata cambiata all’ultimo momento, ci avevano comunicato che non avremmo più potuto raggiungere Yer Sale a causa di una violenta tempesta di neve che avrebbe probabilmente reso difficile il nostro arrivo. Avevamo optato per un nuovo villaggio a Nadym, più a sud, che purtroppo non ci avrebbe permesso l’ingresso della penisola dello Jamal, ma d’altronde questi non sono viaggi dove tutto può essere pianificato. Nonostante il cambiamento di rotta, le difficoltà furono tante e più di una volta i nostri “Panzer” dovettero ricorrere all’uso dell’argano aggrappandosi a quei pochi alberi presenti nella desolazione più bianca. Solo una sosta, a metà strada, presso un fatiscente punto di ristoro: una vecchia baracca abbandonata dove un anziano militare in pensione viveva da eremita. Ci accolse con un sorriso dagli occhi tristi ed inquietanti assolutamente incapaci di nascondere le atrocità delle sue guerre. L’incontro con i Nenets avvenne con quattro ore di ritardo, era circa mezzanotte quando i nostri fuoristrada improvvisamente si fermarono nel nulla.
Era ora di scendere!
Ad attenderci, due sagome avvolte dal buio e da pesanti pellicce di renna. Su loro invito ci “accomodammo” in robusti e rudimentali cassoni di legno: “le promesse slitte”, insieme ai nostri innumerevoli e quanto mai inutili bagagli occidentali. Le renne sostituite da una potente moto slitta; Aleksandr Serotetta, capo della 17° brigata ai tempi dei racconti di Fen Montaigne e Maria Stensel, sostituito dal figlio Yuri. Il tanto sognato “magico viaggio di Babbo Natale” dietro le bianche renne fu sostituito da uno shakerato trasporto dietro una roboante moto capace di alzare nuvole di neve e ghiaccio sui nostri volti. Senz’altro il primo segno del tempo che era passato.
Partenza!
Dieci minuti, sufficienti a scatenare violenti dolori in tutto il corpo.
All’improvviso, dal bianco notturno della Taiga, piccoli punti sempre più distinguibili svelarono le sagome di quattro Chum, come quelli degli indiani d’America del nostro immaginario collettivo. Il villaggio era davanti a noi, ci erano voluti due giorni e più di 7.000 Km, per essere catapultati in un nuovo mondo! Un mondo dove tutto è legato alla abilità dell’uomo, dove il superfluo non può esistere ed il necessario deve essere ogni giorno conquistato e ricercato con la fatica e l’abilità che solo in certe situazioni è possibile trovare.
 Se non fosse stato per l’abbaiare incessante di una ventina di cani Samoiedo, che affiancati alle slitte ci avevano scortato per gli ultimi cento metri all’interno dei loro confini, spenti i motori, il silenzio sarebbe stato totale. La luna rubava buio alla notte e la neve si pavoneggiava sotto i suoi raggi.
Se non fosse stato per l’abbaiare incessante di una ventina di cani Samoiedo, che affiancati alle slitte ci avevano scortato per gli ultimi cento metri all’interno dei loro confini, spenti i motori, il silenzio sarebbe stato totale. La luna rubava buio alla notte e la neve si pavoneggiava sotto i suoi raggi.
La discesa dalla slitta fu quanto mai rocambolesca, la prima gamba sprofondò fino al ginocchio e, nel tentativo di liberarla, la seconda si inabissò fino all’anca! Non una parola, ma la presenza di una possente mano, al disotto della mia ascella, trasformò il mio peso in quello di una morbida piuma. Non meno goffo l’ingresso nella tenda. Solo dopo alcuni giorni riuscimmo ad intuirne la tecnica. Bisognava spostare due pesanti strati di pelli di renna per accedere al suo interno attraverso un’apertura non più alta di un metro. Questa operazione doveva essere fatta di spalle prendendo le pelli con la mano incrociata davanti a noi e ruotando il corpo in modo da entrare di schiena. Quella sera non andò proprio così! Mi trovai disteso per terra per la spinta posteriore delle pelli sul mio corpo, gli occhiali completamente appannati per il tepore della stufa, lasciata eccezionalmente accesa in nostro onore, e sommerso da una muta di cani accorsi a salutare l’intruso. Ci vollero pochi secondi per scoprire di essere capitato in un luogo affollato, sette persone distese e sonnecchianti che apparentemente non mi degnarono nemmeno di uno sguardo.
Ci indicarono i nostri posti.
In silenzio e distrutto dal lungo viaggio a malapena riuscii a srotolare il sacco a pelo e infilarmici in cerca di un nascondiglio sicuro e di riposo. Fu difficile prendere sonno in preda ai dubbi più feroci: “dove mi laverò domani? Come farò a cambiarmi? Come sopravvivrò una settimana senza nemmeno una sedia? e, tragedia, dove e come farò a farla?!” Le risposte non tardarono a venire. Perché lavarsi? Il grasso protegge dal freddo! E cambiarsi? Sarebbe stato davvero difficile sudare. E per quella cosa lì… bè lo spazio fuori non mancava! Mi sarei allontanato 500 metri fino a diventare un puntino così piccolo all’orizzonte da sfuggire allo sguardo indiscreto, ma sicuramente anche poco interessato, alle mie funzioni corporali.
Il primo giorno.
Quel mattino, la luce cominciò a filtrare attraverso il piccolo foro sull’estremità della tenda che dava passaggio al tubo di sfiato della nostra stufa. La struttura cominciò a svelarsi: più di 60 pali di betulla sagomati a mano si intrecciavano come uno shanghai in un unico punto facendo da telaio a due pesanti teli costituiti da due strati di pelli di renna cuciti assieme.
 Poca luce filtrava da una piccola finestra di nylon sulla parete laterale e il primo raggio di sole illuminò il volto di un bambino: Vova, come un angelo, disteso tra Yuri ed Elèna e poi, ordinatamente: Tatiana, Laura, Nicoletta. Dal mio lato Aleksandr, Antonina, Dimitri, Aleksej…io. Eravamo li: “nelle vite degli altri”!
Poca luce filtrava da una piccola finestra di nylon sulla parete laterale e il primo raggio di sole illuminò il volto di un bambino: Vova, come un angelo, disteso tra Yuri ed Elèna e poi, ordinatamente: Tatiana, Laura, Nicoletta. Dal mio lato Aleksandr, Antonina, Dimitri, Aleksej…io. Eravamo li: “nelle vite degli altri”!
Ancora qualche minuto e la tenda si sarebbe animata per la prima volta davanti ai nostri occhi. Dopo aver riattivato la stufa, Antonina recuperò un basso tavolo, direi 10 cm, non più, ma pieno di ogni genere alimentare: latte in scatola, biscotti, marmellata, Nescafé ed ancora, pesce crudo, carne secca, pane raffermo…senape. Un rito dal miscuglio di sapori che, ben presto capii, sarebbe stato riproposto più volte al giorno e in tutti i giorni a venire. Poche parole, pochi gesti, sguardi, ma sufficienti a stabilire un contatto.
Questa è l’ospitalità: tutto in comune, tutto in condivisione. Ognuno a modo proprio, noi alla ricerca di tovaglioli e cucchiaini, loro servendosi delle grosse dita intinte nel latte condensato e di affilati coltelli per tagliare forme di pane rinsecchito. Reciproca curiosità: due mondi che cercavano di fondersi pur lasciando traccia alla loro confluenza come l’incontro di due mari.
Tutte le mattine lo stesso rito, l’accensione delle moto slitte!
Gesto quanto mai ovvio, andavano scaldate, ma forte e pieno di orgoglio: status symbol o insostituibile necessità?
Le avevano naturalmente solo gli uomini, quelli che nella tenda potevano stendere i propri indumenti bagnati ad una lunga pertica sopra la stufa, quelli che potevano andare dietro la stufa o dietro la tenda! Le donne no, loro potevano fare i propri bisogni solo davanti alla tenda, 50 mt più in là mentre lo spazio dietro la stufa e dietro la tenda era considerato sacro, pertanto era lo spazio degli Dei e per gli uomini.
“Sali” mi disse, o così pensai di aver capito.
Dietro di Lui, nel vento, verso il nulla, a 80-100 km/h dietro le sue spalle. “Come volare” … poi una rapida virata e di nuovo… nel vento, verso il ritorno. Yuri mi aveva portato con sé, insieme avevamo scaldato i motori, mi aveva confermato la sua stima, la sua considerazione, invitandomi alla prova del coraggio come su un cavallo, mi aveva validato la sua ospitalità. Essere capo di una Brigata significa saper prendere le decisioni giuste per tutti ed in ogni situazione; i pericoli, anche se noti, sono sempre in agguato. Saper decidere tempi e modi non è cosa da poco!
Costituite dal regime sovietico, le brigate avrebbero dovuto frammentare e disgregare i vecchi clan familiari, in realtà il forte legame dei Nenets non ha mai permesso che ciò accadesse né, mai, l’assetto militare è riuscito a separare un popolo di nomadi da generazioni dedicati alla “cultura della renna”.
“Si smonta, si parte”.
Una volta a settimana, a volte anche più spesso, il campo doveva spostarsi. Le 10.000 renne della brigata di Yuri erano capaci, in soli tre giorni, di traforare interi ettari di terreno e saccheggiare intere distese di licheni. Le partenze non avvenivano quasi mai tutti insieme quindi le renne dovevano essere separate. Abbiamo assistito ad uno dei più esaltanti ed emozionanti spettacoli della nostra vita! Un incrocio tra un rodeo e una danza. 10.000 renne incitate alla corsa, sospinte da una parte dai cani e respinte dall’altra dalle moto lanciate alla rincorsa.
Viste dall’alto, con il mio drone, sembrava di assistere alla migrazione degli gnu nel parco del Serengeti. In mezzo, loro, non più di dieci uomini, immobili come ghepardi, pronti a riconoscerle e a scattare con i loro lazzi. Un rapido gesto, un lancio, venti metri di corda librati nell’aria, un incastro perfetto tra le ramificate corna delle femmine o sui forti colli dei maschi.
Era difficile per loro sbagliare, quasi impossibile, ogni tiro un centro, ogni volta la renna giusta! Quella tra 10.000!
“Come solo un padre riconosce il proprio figlio”, così solo un Nenet sa riconoscere la propria renna.
Rapidamente immobilizzate sul manto nevoso rimasero immobili fino alla fine della battaglia, fino al tramonto, quando ormai esauste, allontanate le altre, furono slegate e ricostituite in un nuovo branco. Io corsi per l’intero giorno, infilandomi nella neve alta, cadendo e rialzandomi più volte, ogni volta con più fatica e più dolore. Loro con i loro lazzi, io con la mia fotocamera. Avevo condiviso, tra sguardi e sorrisi di intesa, una giornata della loro vita.
Tatiana riuscì ogni sera a guadagnare sempre più confidenza e familiarità. Con Vova, durante il giorno, lo slittino era il nostro strumento di comunicazione e di gioco, in tenda intraprendevamo lotte e sparatorie. Il cellulare, oggetto quanto mai inutile dato la mancanza di rete, custodiva all’interno parte delle nostre vite e così pian piano iniziammo a mostrare le nostre famiglie, loro il resto dei figli che d’inverno venivano avviati ai college per studiare. La scolarità è buona nella regione ma, indipendentemente dal titolo di studio raggiunto, quasi tutti ritornano, alla fine delle scuole, alle loro famiglie e alla loro attitudine preferita: l’allevamento delle renne. La Siberia è nel loro DNA, gli spazi infiniti, il silenzio, il bianco dell’inverno come i pascoli fioriti dell’estate, non potranno mai essere sostituiti dalle “fredde” città sovietiche.
Partenze…arrivi.
Nel villaggio accanto si era deciso di andare via. Per loro era già primavera, l’estate si stava avvicinando, ci trovavamo ad una cinquantina di km. a sud del golfo di Ob bisognava risalire la penisola dello Jamal dove le renne avrebbero potuto far nascere i propri piccoli. È sorprendente come le tende possano essere smontate in così poco tempo! Tutto il campo era all’opera, noi arrivammo dal campo vicino per dare una mano, ma in realtà per fermare con le immagini quello che dentro di noi avrebbe continuato a scorrere per tutta la vita.
Se dovessi pensare ad un balletto penserei al “Walzer dei fiori” di Tchaikovsky, se dovessi pensare ad un quadro penserei alla “Lezione di danza” di Edgar Degas. Dall’alto del cielo, con il drone, in veste di spettatore, ma intrufolato dietro le quinte, ad assistere con attenzione ai loro gesti più spontanei, naturali, abituali. Instancabili, ognuno con un compito preciso, con un coordinamento capillare e attenti a che nulla andasse perso. In meno di 10 minuti della tenda rimase solo un’impronta circolare sulla neve. Le slitte, ordinatamente disposte davanti alla tenda, furono caricate di ogni bene e unite alle renne, scelte in base alla loro capacità di traino e ornate di fregi e stemmi da festa.
Una sola ora.
Una lunga fila di uomini, cani, renne, slitte, donne, silenziosa e bianca come la scia di un aereo piano piano si dissolse all’orizzonte. Venti km, forse meno forse più, ma comunque non molti, la notte sarebbe diventata presto gelida e tutto dal nulla sarebbe dovuto riapparire.
Sette giorni sono un attimo nel nuovo mondo e gli stimoli danno tali scariche di adrenalina da accelerare il battito del cuore ed aumentare il ritmo del tempo tanto da farci ritrovare in poco tempo già alla fine del nostro viaggio.
Il disgelo era avvenuto, la comunicazione a sguardi sostituita da dialoghi dai suoni incomprensibili ma dai concetti ben chiari. Stavamo ormai per partire. Avevo imparato molto da quel viaggio. Non ci sarei riuscito, ma sicuramente avrei potuto, da quel giorno, fare a meno di molte cose, avrei potuto cercare di vivere un ritmo molto più umano; “chi ha fretta nella tundra ha fretta di morire” recita un proverbio siberiano.
Montando sul cassone che ci avrebbe riportato ai nostri fuoristrada, avevo detto ai miei amici: “ora non tirate fuori la lacrimuccia!” in realtà lo stavo dicendo a me stesso perché sapevo bene che il distacco sarebbe stato doloroso.
L’ultima foto di gruppo, una stretta di mano, sguardi e poi via.
I Chum tornarono a diventare puntini nella neve… mi trovai solo, a canticchiare un vecchio motivo di Louis Armstrong:
 The colours of the rainbow, so pretty in the sky
The colours of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shakin’ hands, sayin’ How do you do?
They’re really saying I love you
I hear babies cryin’, I watch them grow
They’ll learn much more than I’ll ever know
And I think to myself, what a wonderful world
Yes, I think to myself, what a wonderful world
Proiezione Multimediale
Galleria Fotografica